Tendenze, significati e miti legati al consumo del cibo nel mondo contemporaneo. Quando ci muoviamo tra le corsie di un supermercato e ci salta all’occhio questo o quel prodotto, agiamo in maniera quasi del tutto inconsapevole, influenzati da fattori e sensazioni che siamo abituati a considerare secondari. Ma da che cosa dipende la scelta di un prodotto piuttosto che un altro? Quanto conta l’aspetto esteriore delle confezioni nei nostri comportamenti d’acquisto? Perché gli alimenti per celiaci ci fanno pensare (il più delle volte erroneamente) a qualcosa di “sano” e “genuino”? Ci siamo fatti spiegare tutto (o quasi!) dal Dott. Giuseppe Segreto, che nella vita si occupa di indagare proprio questo tipo di meccanismi.
Domanda di rito: chi è Giuseppe Segreto?
È un ricercatore a contratto presso il Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena. Applica le teorie e i metodi di analisi della semiotica al marketing e allo studio dei media (in particolare, negli ultimi anni, di quelli digitali). In qualità di consulente per la comunicazione, lavora per aziende, istituzioni e organizzazioni non profit. Ha 36 anni, è sposato ed ha un figlio.

Immagine da http://www.dispoc.unisi.it/it/dipartimento/persone/collaboratori/giuseppe-segreto
Che cosa vuol dire occuparsi di semiotica e, in particolare, di semiotica del cibo?
Occuparsi di semiotica significa innanzitutto non smettere mai di “lavorare”. Perché il semiologo non si accontenta di capire i significati del mondo che lo circonda, ma è portato inevitabilmente a riflettere sui meccanismi, spesso poco evidenti, che hanno prodotto quei significati. Agli occhi del semiologo, in altre parole, la realtà è un reticolo di testi, da intendere, però, in un’accezione ben più vasta (e complessa) di come sono intesi i testi dal senso comune. Certo, sono testi gli spot pubblicitari e gli articoli di un quotidiano, ma, per la semiotica, sono testi anche le pratiche gestuali di una determinata sottocultura giovanile, l’organizzazione degli scaffali in una corsia del supermercato o, per l’appunto, la ricetta della pasta con le sarde, vero e proprio manifesto della cucina siciliana. E qui veniamo alla seconda parte della domanda. La semiotica del cibo, infatti, considera le pratiche alimentari alla stessa stregua di un linguaggio. Consideriamo, per esempio, la cucina. Essa possiede parole (i prodotti, gli ingredienti), che si organizzano secondo regole di grammatica (le ricette), di sintassi (i menu) e di retorica (i comportamenti conviviali). Il cibo, insomma, bisogno primario del corpo, rivela, agli occhi del semiologo, una straordinaria dimensione comunicativa da indagare. Perché il cibo parla del mondo e parla di noi.
Che cosa rappresenta il cibo per gli esseri umani e come è cambiato, nel tempo, il nostro rapporto con esso? Penso, ad esempio, al nostro modo di stare a tavola, alle risorse economiche che destiniamo ai prodotti alimentari, o alla maniera in cui organizziamo le nostre dispense.
Il cibo – ce lo hanno insegnato gli antropologi – è uno «strumento simbolico per eccellenza». Le pratiche alimentari segnano i confini fra classi sociali, regioni geografiche, culture, generi sessuali, periodi del ciclo di vita, religioni; servono a distinguere riti, tradizioni, feste, stagioni dell’anno e momenti della giornata.
Ora, se è vero che le strutture profonde si mantengono, è anche vero che i significati socioculturali hanno una natura dinamica. Una prima considerazione, a questo proposito, merita di essere fatta in relazione alle trasformazioni dei processi produttivi riguardanti il cibo. Nel nostro Paese, a partire dal secondo dopoguerra, è avvenuta una vera e propria rivoluzione produttiva che, da un lato, ha imboccato la strada di una sempre maggiore industrializzazione e, dall’altro, ha modificato lo statuto dell’agricoltura, trasformandola da fornitrice di cibo in fornitrice di materie prime per l’industria. L’alimentazione è diventata così un mercato di consumo di massa e il cibo ha cambiato pelle, diventando prodotto e, sempre di più, anche servizio. Negli anni Novanta si è assistito ad un fenomeno inverso: il disagio ingenerato da un sistema alimentare sempre più omologato e straniato dal territorio ha generato inedite forme di “nostalgia per la campagna“, la quale, a sua volta, ha portato alla ricostruzione, più simbolica che reale, della cosiddetta “cucina del territorio”. A questo fenomeno si sono accompagnati poi i cambiamenti intervenuti a proposito dei valori dietetici. Il cibo è ormai passato dal terreno specialistico dei nutrizionisti al discorso sociale dell’intero pubblico, anche se si tratta, come capita spesso, di una razionalizzazione fortemente intrisa di rappresentazioni mitiche (si pensi al mito del light e alla contraddizione di voler “alleggerire” alimenti di per sé pesanti come la maionese o gli snack al cioccolato). Gli ultimi anni, infine, sono il regno, per dirla con le parole di Gianfranco Marrone, della Gastromania, del profluvio di programmi tv dedicati alla cucina, dei cuochi divenuti star, dei tour enogastronomici organizzati a tutte le latitudini, dell’ossessione per il chilometro 0, delle migliaia di food blog che attraversano la Rete, della condivisione infinita di immagini di piatti e prodotti alimentari su Instagram e Twitter. E l’elenco non è affatto esaustivo.
Il cibo per come lo si intende oggi è anche, e forse soprattutto, convivialità. Il celiaco appartiene ad una “minoranza alimentare” che, a differenza del veganismo o del crudismo, non è il risultato di una libera scelta, bensì di una necessità. Quali ripercussioni può avere, sul piano sociale, l’essere affetti da una patologia che chiama in causa il cibo e che può quindi compromettere la dimensione della convivialità?
Il cibo ha sempre svolto una funzione di collante sociale. Greci e Latini, volendosi auto-rappresentare come area della “civiltà” contrapposta all’universo estraneo della barbarie, insistevano molto sul fatto che loro mangiassero “insieme”. Il convivium, in altre parole, è l’immagine stessa della vita in comune (cum vivere). È chiaro quindi che, essendo in gioco il senso di appartenenza degli individui ad una comunità, il problema della celiachia va affrontato con attenzione e assoluto rispetto. Non è un caso che, spesso, i racconti delle persone celiache si concentrino maggiormente, soprattutto nella fase della scoperta della malattia, sui contraccolpi psicologici più che su quelli fisici. Oggi, per fortuna, ci sono una sensibilità e, soprattutto, un’offerta di alternative gluten free molto maggiore rispetto al passato. Sono nati negozi e minimarket senza glutine, ma anche panifici, pasticcerie e ristoranti, che hanno finito per spogliare la condizione dei celiaci di quell’aura di malattia e di privazione ed hanno costituito un’offerta valida anche in termini di bontà e gratificazione del gusto. Di conseguenza, appartenere a questa “minoranza alimentare”, risulta (almeno agli occhi di chi, come me, celiaco non è) meno discriminante di un tempo.
Che tipo di consumatore è l’acquirente celiaco?
Il minimo che si possa dire è che si tratta di un acquirente informato. È un consumatore che combatte contro lo spettro della contaminazione e che legge con grande attenzione le etichette, assicurandosi che la tracciabilità e la trasparenza dei processi di produzione e trasformazione siano rispettati. Il consumatore celiaco, in fondo, stabilisce un contratto di fiducia sia nei confronti delle marche che sovrintendono alla sua alimentazione sia nei confronti del distributore, che “apparecchia” per lui uno spazio a sé e garantisce che il cibo presente su quello scaffale sia buono, sano e sicuro.
Fino a pochissimi anni fa la reperibilità dei prodotti senza glutine era limitata alle farmacie. Oggi, fortunatamente, i celiaci possono avvalersi anche della grande distribuzione organizzata. Come sono disposti gli articoli senza glutine sugli scaffali dei supermercati e che cosa possiamo dire, in generale, del visual merchindising relativo a questi prodotti?
Innanzitutto occorre fare una riflessione sulla collocazione spaziale degli articoli senza glutine all’interno dei supermercati. Gli scaffali dedicati ai prodotti dalla spiga barrata non sono nascosti, non si disperdono lungo le corsie dedicate al resto delle categorie merceologiche, ma sono posizionati in zone strategiche, quelle di grande passaggio, di grande visibilità (è quasi impossibile non vederli). Li troviamo, infatti, sui larghi corridoi che circondano le corsie, oppure fra una corsia e l’altra, in quello spazio – preziosissimo dal punto di vista commerciale – definito testata di gondola, quello, per capirci, dove in genere vengono posizionati i prodotti in promozione. Sono spazi di vendita che richiamano, direi quasi estremizzano, l’estetica bio. Si prediligono i colori tenui (il giallo paglierino, il color crema, il bianco) e i materiali grezzi (legno, marmo). Ma, in generale, è tutto l’allestimento a comunicare la propria vicinanza alla natura e al sano.
In che misura l’aspetto di una confezione riesce a orientare i nostri acquisti?
Molto. Lo studio del packaging riveste un ruolo sempre più importante all’interno delle strategie di comunicazione con cui i prodotti vengono immessi sul mercato. La confezione è il medium principale, insieme al nome, che la marca sfrutta per farsi conoscere e riconoscere dai consumatori. Come abbiamo detto, nel caso dei prodotti senza glutine dominano i colori chiari, a partire dal giallo paglierino. Le farine, i prodotti da forno in generale, diventano accessibili fin dalla configurazione visiva dello scaffale, che richiama i codici estetici del forno. Le confezioni, poi, si caratterizzano per la presenza costante di trasparenze. Una tendenza che riscontriamo anche nel confezionamento dei prodotti alimentari in generale ma che, con riferimento ai prodotti senza glutine, risulta sicuramente più accentuata. Qui, più che mai, il cibo si deve vedere. Si deve vedere ma anche toccare. Per questo il packaging è morbido, richiama le confezioni alimentari del passato (la carta del droghiere… i buoni prodotti di una volta). Tuttavia, al tatto, la texture di tali confezioni non è ruvida (il vintage è dato dall’immagine) ma liscia, plasticosa. Viene quindi trasmessa una sensazione di pulito e, in ultima istanza, di sano. In questo il packaging gluten free richiama ancora la sua origine medicale e farmaceutica.
Sempre a proposito di packaging: l’estetica e la comunicazione del prodotto alimentare sono state investite, in anni recenti, da una sorta di “filone della natura”. Crede che questa strategia stia riguardando anche i prodotti gluten free, portando all’idea che “senza glutine” significhi, si per sé, sano?
Certamente. Come abbiamo detto, l’estetica complessiva degli spazi di vendita gluten free richiama la natura o, per meglio dire, il concetto di naturale e incontaminato così come è stato costruito nell’immaginario collettivo dall’industria alimentare da almeno un paio di decenni a questa parte (come non ricordare, a questo proposito, gli spot che “mostrano” l’oasi Plasmon…). L’implicito è che la natura sia sinonimo di sano. In realtà, come sappiamo, la natura non è solo ridens: è anche sporca, deforme, puzzolente. Ma questo è un altro discorso. E non riguarda solo i prodotti senza glutine…
Stando a Google Trends, l’Italia è al primo posto al mondo per numero di ricerche sul web riguardo alla malattia celiaca. Come si spiega, secondo lei, questo dato? È lecito sospettare che sia anche una questione di “moda” e che il mercato stia avendo un ruolo notevole in questo processo?
Sì, non si può disconoscere questa tendenza, né il ruolo del marketing. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una impennata della dieta senza glutine, a prescindere dalla diffusione della malattia celiaca. Si è affermato il concetto che “gluten free” sia comunque sano, da qui anche l’acquisto e il consumo di questi prodotti da parte di gente non affetta da celiachia. Il fatto poi che alcune star di Hollywood abbiano dichiarato di avere adottato, pur non essendo celiache, una dieta senza glutine, con effetti benefici sulla loro brillante forma fisica e sul loro successo professionale, beh, mi sembra che chiuda il cerchio.
L’AIC ha più volte ribadito che tutti i cosmetici e tutti i tipi di acqua confezionata sono idonei per i celiaci. Eppure, alcune aziende produttrici hanno cominciato ad apporvi la dicitura “senza glutine”, inducendo il consumatore a credere che, in assenza di una tale dicitura, il prodotto sia da considerarsi a rischio. Che opinione ha di queste strategie di marketing?
I consumi del gluten free sono in crescita costante. È un mercato che, a differenza di altri, risulta ancora molto profittevole. Non mi sorprende che molte grandi marche vi si siano buttate a capofitto, anche con strategie come questa, sicuramente discutibili sul piano etico.
Quali accortezze adotta, secondo lei, un consumatore attento e consapevole? Può dare qualche consiglio o informazione utile ai nostri lettori?
Il consumatore attento e consapevole fa la lista della spesa prima di uscire di casa e cerca di attenersi il più possibile a quell’elenco di prodotti di cui ha effettivamente bisogno, senza cedere così alle lusinghe delle promozioni o alle strategie di vendita della grande distribuzione. È un consumatore che cerca di osservare lo scaffale nella sua interezza ed è disposto ad abbassarsi per tenere in considerazione anche l’ultimo ripiano in basso. Qualche consiglio? Se può, vada a fare la spesa in posti diversi: vada nei mercati, cerchi di avere un ortolano, un pescivendolo o un macellaio di fiducia. Si prenda il suo tempo.














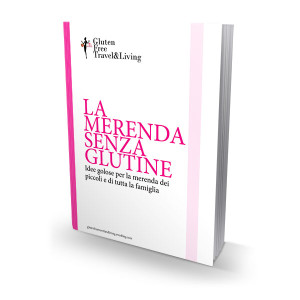
un articolo di altissima qualità e pieno di interesse!
Pingback: Vino vegano: intervista a Marilina Paternò – Gluten Free Travel and Living